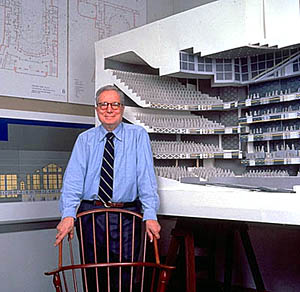Anche questo intervento (critico) dello scrittore Edward Docx fa in qualche modo parte del dibattito sul pensiero debole e sul postmoderno.
Al fondo, invece, un breve intervento dell'architetto Denise Scott Brown, tratto dal catalogo della mostra al Victoria and Albert Museum.
Addio postmoderno
Benvenuti nell'era dell'autenticità
Edward Docx - La Repubblica, 3 settembre 2011
Ho delle buone notizie per voi. Il 24 settembre potremo ufficialmente dichiarare morto il postmoderno. Come faccio a saperlo? Perché in quella data al Victoria and Albert Museum si inaugurerà quella che viene definita la "prima retrospettiva globale" al mondo intitolata "Postmoderno: stile e sovversione 1970-1990".
Un momento.... Vi sento urlare. Perché dichiarano ciò? Che cosa è stato il postmoderno, dopo tutto? Non l'ho mai capito. Come è possibile che sia finito? Non siete gli unici. Se esiste una parola che confonde, irrita, infastidisce, assilla, esaurisce e contamina noi tutti è "postmoderno". E nondimeno, se lo si capisce, il postmodernismo è scherzoso, intelligente, divertente, affascinante. Da Madonna a Lady Gaga, da Paul Auster a David Foster Wallace, la sua influenza è arrivata ovunque e tuttora si espande. È stata l'idea predominante della nostra epoca.
Allora: di che cosa si è trattato, esattamente? Beh, il modo migliore per iniziare a capire il postmodernismo è facendo riferimento a ciò che c'era prima: il modernismo. A differenza, per esempio, dell'Illuminismo o del Romanticismo, il postmodernismo racchiude in sé il movimento che si prefiggeva di ribaltare. A modo suo, il postmodernismo potrebbe essere considerato come il tardivo sbocciare di un seme più vecchio, piantato da artisti quali Marcel Duchamp, all'apice del modernismo tra gli anni Venti e Trenta. Di conseguenza, se i modernisti come Picasso e Cézanne si concentrarono sul design, sulla maestria, sull'unicità e sulla straordinarietà, i postmoderni come Andy Warhol e Willem de Kooning si sono concentrati sulla mescolanza, l'opportunità, la ripetizione. Se i modernisti come Virginia Woolf apprezzarono la profondità e la metafisica, i postmoderni come Martin Amis hanno preferito l'apparenza e l'ironia. In altre parole: il modernismo predilesse una profonda competenza, ambì a essere europeo e si occupò di universale. Il postmodernismo ha prediletto i prodotti di consumo e l'America, e ha abbracciato tutte le situazioni possibili al mondo.
I primi postmodernisti si legarono in un movimento di forte impatto, che mirava a rompere col passato. Ne derivò una permissività nuova e radicale. Il postmodernismo è stato una rivolta apprezzabilmente dinamica, un insieme di attività critiche e retoriche che si prefiggevano di destabilizzare le pietre miliari moderniste dell'identità, del progresso storico e della certezza epistemica. Più di ogni altra cosa il postmodernismo è stato un modo di pensare e di fare che ha cercato di eliminare ogni sorta di privilegio da qualsiasi carattere particolare e di sconfessare il consenso del gusto. Come tutte le grandi idee, è stato una tendenza artistica evolutasi fino ad assumere significato sociale e politico. Come ha detto il filosofo egiziano-americano Ihab Hassan, nella nostra epoca si è affermato un "forte desiderio di dis-fare, che ha preso di mira la struttura politica, la struttura cognitiva, la struttura erotica, la psiche dell'individuo, l'intero territorio del dibattito occidentale".
Il postmodernismo apparve per la prima volta come termine filosofico nel libro del 1979 dell'intellettuale francese Jean-François Lyotard intitolato "The Postmodern Condition", nel quale si affermava che gruppi diversi di persone utilizzano il medesimo idioma in modi differenti e ciò implica che possano arrivare a vedere il mondo con occhi alquanto differenti e personali. Così, per esempio, il sacerdote utilizza il termine "verità" in modo assai diverso dallo scienziato, che a sua volta intende la medesima locuzione in modo ancora diverso rispetto a un artista. Di conseguenza, svanisce completamente il concetto di una visione unica del mondo, di una visione predominante. Se ne deduce - sostenne ancora Lyotard - che tutte le interpretazioni convivono, e sono su uno stesso piano. Questo confluire di interpretazioni costituisce l'essenza del postmodernismo.
Purtroppo, il 75% di tutto ciò che è stato scritto su questo movimento è contraddittorio, inconciliabile, oppure emblematico della spazzatura che ha danneggiato il mondo accademico della linguistica e della filosofia "continentale" per troppo tempo. Non tutto però è da buttar via. Due sono gli elementi importanti. Il primo è che il postmodernismo è un'offensiva non soltanto all'interpretazione dominante, ma anche al dibattito sociale imperante. Ogni forma d'arte è filosofia e ogni filosofia è politica. Il confronto epistemico del postmodernismo, l'idea di de-privilegiarne un significato, ha pertanto condotto ad alcune conquiste utili per il genere umano. Se infatti ci si impegna per sfidare il ragionamento prevalente e predominante, ci si impegna altresì per dare voce a gruppi fino a quel momento emarginati. Così il postmodernismo ha aiutato la società occidentale a comprendere la politica della differenza e quindi a correggere le miserabili iniquità ignorate fino a quel momento. Il secondo punto va maggiormente in profondità. Il postmodernismo mirava a qualcosa di più che pretendere semplicemente una rivalutazione delle strutture del potere. Affermava che noi tutti come esseri umani altro non siamo che aggregati di quelle strutture. Sosteneva che non possiamo prendere le distanze dalle richieste e dalle identità che tali discorsi ci presentano. Adios, Illuminismo. Bye bye, Romanticismo. Il postmodernismo, invece, afferma che ci muoviamo attraverso una serie di coordinate su vari fronti - classe sociale, genere, sesso, etnia - e che queste coordinate di fatto costituiscono la nostra unica identità. Altro non c'è. Questa è la sfida fondamentale che il postmodernismo ha portato al grande convivio delle idee umane, in quanto ha cambiato il gioco, passando dall'autodeterminazione alla determinazione dell'altro.
Eccoci però giunti alla domanda trabocchetto, la più subdola di tutte: come sappiamo che il postmodernismo è alla fine, e perché? Prendiamo in considerazione le arti, la linea del fronte. Non si può affermare che l'impatto del postmodernismo sia minore o in via di estinzione. Anzi, il postmodernismo è esso stesso diventato il sostituito dell'ideologia dominante, e sta prendendo posto nella gamma di possibilità artistiche e intellettuali, accanto a tutte le altre grandi idee. Tutti questi movimenti in modo impercettibile plasmano la nostra immaginazione e il modo col quale creiamo e interagiamo. Ma, sempre più spesso, il postmodernismo sta diventando "soltanto" una delle possibilità che possiamo utilizzare. Perché? Perché tutti noi siamo sempre più a nostro agio con l'idea di avere in testa due concetti inconciliabili: che nessun sistema di significato possa detenere il monopolio sulla verità, e che nondimeno dobbiamo riformulare la verità tramite il nostro sistema scelto di significati.

Forse, il modo migliore per spiegare le ragioni di questo sviluppo è usare la mia forma d'arte, il romanzo. Il postmodernismo ha influito sulla letteratura sin da quando sono nato. In effetti, il modo stesso col quale ho scritto questo articolo - mescolando parzialmente a livello di consapevolezza tono formale e tono informale - è in debito verso le sue stesse idee. Stile alto e stile basso coesistono allo scopo precipuo di creare occasioni di stupore, sorpresa, introspezione. Il problema, però, è quello che potremmo definire il paradosso del postmodernismo. Per qualche tempo, quando il Comunismo crollò, la supremazia del capitalismo occidentale parve messo a dura prova proprio ricorrendo alle tattiche ironiche del postmodernismo. Col passare del tempo, però, si è presentata una nuova difficoltà: tenuto conto che il postmodernismo se la prende con qualsiasi cosa, ha iniziato ad affermarsi una sensazione di confusione, finché negli ultimi anni è diventata onnipresente. Una mancanza di fiducia nei dogmi e nell'estetica della letteratura ha permeato la cultura e pochi si sono sentiti sicuri o esperti a sufficienza da riuscire a distinguere la spazzatura da ciò che non lo è. Pertanto, in assenza di criteri estetici attendibili, è diventato sempre più conveniente stimare il valore delle opere in rapporto ai guadagni che esse assicuravano. Così, paradossalmente, siamo arrivati a una fase nella quale la letteratura stessa è ormai minacciata, prima dal dogma artistico del postmodernismo, poi dagli effetti involontari di tale dogma, l'egemonia dei marketplace.
Esiste inoltre un paradosso parallelo, in politica e in filosofia. Se deprivilegiamo tutte le posizioni, non possiamo affermare alcuna posizione, pertanto non possiamo prendere parte alla società e quindi, in definitiva, un postmodernismo aggressivo diventa indistinguibile da una specie di inerte conservatorismo. La soluzione postmoderna non servirà più da risposta al mondo nel quale ci ritroviamo a vivere. In quanto esseri umani, noi non desideriamo esplicitamente essere lasciati in compagnia del solo mercato. Perfino i miliardari vogliono essere collezionisti di opere d'arte. Certo, internet è quanto di più postmoderno esista su questo pianeta. Il suo effetto più immediato in Occidente pare essere stato la nascita di una generazione che è maggiormente interessata ai social network che alla rivoluzione sociale. Tuttavia, se sappiamo guardare oltre scopriamo un secondo effetto negativo indesiderato: una smania a conseguire una sorta di veridicità offline. Desideriamo essere riscattati dalla volgarità dei nostri consumi, dalla simulazione del nostro continuo atteggiarci.
Se il problema per i postmodernisti è stato che i modernisti avevano detto loro che cosa fare, allora il problema dell'attuale generazione è esattamente il contrario: nessuno ci sta dicendo che cosa fare. Questo crescente desiderio di una maggiore veridicità ci circonda da tutte le parti. Lo possiamo constatare nella specificità dei movimenti food local, per i cibi a chilometro zero. Lo possiamo riconoscere nelle campagne pubblicitarie che ambiscono ardentemente a raffigurare l'autenticità e non la ribellione. Lo possiamo vedere nel modo col quale i brand stanno cercando di prendere in considerazione un interesse per i valori dell'etica. I valori tornano ad avere importanza. Se andiamo ancor più in profondità, ci accorgiamo della crescente rivalutazione dello scultore che sa scolpire e del romanziere che sa scrivere. Jonathan Franzen ne è un esempio calzante: uno scrittore encomiato in tutto il mondo perché si sottrae alle evasioni di genere o alle strategie narrative postmoderne, cercando invece di dire qualcosa di intelligente, di autentico, scritto bene, sulla propria epoca. Ciò che conta, dopo tutto, non è soltanto la storia, ma come è raccontata. Queste tre idee - specificità, valori, autenticità - sono in aperto conflitto con il postmodernismo. Stiamo dunque entrando in una nuova era. Potremmo provare a chiamarla "l'Età dell'Autenticità". Vediamo un po'come andranno le cose.
(Traduzione di Anna Bissanti)
Imparando da Las Vegas
La Repubblica, 3 settembre 2011
Denise Scott Brown approdò a Las Vegas coi suoi studenti dell'Ucla nel 1965 e poi nel 1968, convincendo il marito Robert Venturi a seguirla. "Learning from Las Vegas" fu il frutto di quelle indagini. Il libro analizzava, senza scomunicarla, la malfamata città del vizio, «una città che spavaldamente sembrava fare a meno non solo degli architetti, ma dell'architettura in generale», scrive Manuel Orazi nella postfazione alla traduzione italiana. Las Vegas cresceva per accumulo di oggetti fastosi e improbabili che si accatastavano sui due lati della Route 91, frutto di speculazione sulle aree. Era l'esempio di come la funzionalità e la razionalità predicate dal movimento moderno potessero infrangersi contro l'irrompere di gusti e di consumi, contro la potenza del mercato. Il libro provocò molte reazioni e Scott Brown e Venturi vennero accusati di snobismo, di apologia del disordine, di giustificare e non solo di studiare.
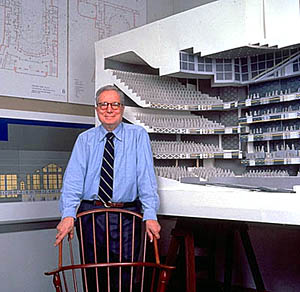 |
| Robert Venturi |
«Robert Venturi e io ci consideriamo ancora postmoderni, ma in un'accezione che deriva dalle arti e dalle scienze umane degli anni Sessanta, o anche prima. Quelle idee ci influenzano tuttora e prendono il nome di "Postmoderno" in molti campi. Siamo al tempo stesso Modernisti, impegnati nel progetto di aggiornare i dogmi del Moderno per avviare un cambiamento. La definizione di Postmoderno non va confusa con la deriva a cui abbiamo assistito in architettura e che chiamo, in senso negativo, "PoMo".
Il "PoMo" ha fatto sì che in passato Venturi negasse di essere postmoderno: è un movimento puramente commerciale che si distingue per quel disprezzo del sociale che in alcuni circoli, dagli anni Settanta in poi, è diventato un marchio distintivo. A causa di questa deriva, anche noi siamo stati accusati di essere superficiali e "ossessionati dai neon".
Al mio grido di allora: "Ci deve essere un modo per incidere sulla società coni nostri progetti", gli architetti "PoMo" hanno risposto: "Possiamo fare davvero poco per risolvere i problemi sociali, allora perché tentare?". A noi, invece, la società interessa. Quando dicevo che il nostro saggio "Imparando da Las Vegas" era in parte un trattato sociale, tutti replicavano: "Stai scherzando!". Ma oggi gli studenti e i giovani architetti rispondono: "Che altro c'è di nuovo?". Ci auguriamo che le nuove generazioni raccolgano la fiaccola (il neon?) e si facciano carico di situazioni tecniche e sociali che noi non siamo in grado di capire perché troppo vecchi e così facendo si mettano al servizio della necessità e raggiungano lo scopo della bellezza (magari straziante)».
(Il testo è un estratto del saggio di Scott Brown scritto per il catalogo della mostra del Victoria & Albert Museum)